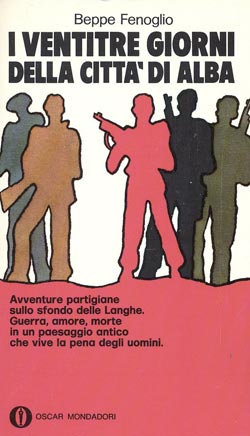
I ventitré giorni della città di Alba è una raccolta di 12 racconti di Beppe Fenoglio. La pubblicazione avvenne nel 1952 e segnò l’esordio letterario dello scrittore piemontese. Il primo episodio narra della conquista partigiana di Alba, avvenuta il 10 ottobre 1944. Privi degli aiuti alleati, i partigiani resistono poche settimane prima di cedere nuovamente la città all’esercito della Repubblica Sociale Italiana il 2 novembre successivo, dopo appunto 23 giorni.
L’opera comprende dodici racconti: sei di vita partigiana e sei di ambiente contadino.
Le vicende si susseguono rapide: Fenoglio registra gli avvenimenti quasi con distacco, fermandosi solo, di tanto in tanto, a colorire una descrizione, a definire un carattere o un rapporto umano.
L’opera comprende dodici racconti: sei di vita partigiana e sei di ambiente contadino.
Le vicende si susseguono rapide: Fenoglio registra gli avvenimenti quasi con distacco, fermandosi solo, di tanto in tanto, a colorire una descrizione, a definire un carattere o un rapporto umano.
“‘I ventitré giorni della città di Alba’, rievocanti episodi partigiani o l’inquietudine dei giovani nel dopoguerra, sono racconti pieni di fatti, con una evidenza cinematografica, con una penetrazione psicologica tutta oggettiva e rivelano un temperamento di narratore crudo ma senza ostentazione, senza compiacenze di stile, asciutto ed esatto”. (Italo Calvino)
Gli eroi dei “Ventitre giorni” sono studenti romantici e individualisti in conflitto con la volgarità dei capi partigiani, oppure soldati-bambini alquanto sbruffoni e incauti o ancora partigiani-ladri increduli della propria condanna persino di fronte al plotone d’esecuzione: a incombere su tutti la guerra civile, trattata come necessità dai risvolti grotteschi, senza commenti lirici, senza la retorica di rito nelle celebrazioni del 25 aprile. (dalle note del libro “La Malora”).
O tu Germania che sei la più forte,
Fatti avanti se ci hai del coraggio,
Se la repubblica ti lascia il passaggio,
Noi partigiani fermarti saprem!
Estratto:
Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novembre dell’anno 1944.
Ai primi d’ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline (non dormivano da settimane, tutte le notti quelli scendevano a far bordello con le armi, erano esauriti gli stessi borghesi che pure non lasciavano più il letto), il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l’incolumità dell’esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò.
I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli, guardando indietro se i partigiani subentranti non li seguivano un po’ troppo dappresso, e qualcuno senza parere faceva corsettine avanti ai camerati, per modo che, se da dietro si sparava un colpo a tradimento, non fosse subito la sua schiena ad incassarlo. Quando poi furono sull’altra sponda e su questa di loro non rimase che polvere ricadente, allora si fermarono e voltarono tutti, e in direzione della libera città di Alba urlarono: – Venduti, bastardi e traditori, ritorneremo e v’impiccheremo tutti! – Poi dalla città furono visti correre a cerchio verso un sol punto: era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mugolavano che si sentivano morire dalla vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza tornarono a rivolgersi alla città e a gridare: – Venduti, bastardi…! – eccetera, ma stavolta un po’ più sostanziosamente, perché non erano tutti improperi quelli che mandavano, c’erano anche mortaiate che riuscirono a dare in seguito un bel profitto ai conciatetti della città.
I partigiani si cacciarono in porte e portoni, i borghesi ruzzolarono in cantina, un paio di squadre corse agli argini da dove apri un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sull’altra riva e fece aria ai repubblicani che però marciaron via di miglior passo.
Allora qualcuno s’attaccò alla fune del campanone della cattedrale, altri alle corde delle campane dell’altre otto chiese di Alba e sembrò che sulla città piovesse scheggioni di bronzo. La gente, ferma o che camminasse, teneva la testa rientrata nelle spalle e aveva la faccia degli ubriachi o quella di chi s’aspetta il solletico in qualche parte. Così la gente, pressata contro i muri di via Maestra, vide passare i partigiani delle Langhe. Non che non n’avesse visti mai, al tempo che in Alba era di guarnigione il II Reggimento Cacciatori degli Appennini e che questi tornavano dall’aver rastrellato una porzione di Langa, ce n’era sempre da vedere uno o due con le mani legate col fildiferro e il muso macellato, ma erano solo uno o due, mentre ora c’erano tutti (come credere che ce ne fossero altri ancora?) e nella loro miglior forma.
Fu la più selvaggia parata della storia moderna: solamente di divise ce n’era per cento carnevali. Fece un’impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell’uniforme di gala di colonnello d’artiglieria cogli alamari neri e le bande gialle e intorno alla vita il cinturone rossonero dei pompieri col grosso gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso e tutti, o quasi, portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti; lesse nomi romantici e formidabili, che andavano da Rolando a Dinamite. Cogli uomini sfilarono le partigiane, in abiti maschili, e qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare: – Ahi, povera Italia! – perché queste ragazze avevano delle facce e un’andatura che i cittadini presero tutti a strizzar l’occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e s’erano scaraventate in città.
A proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare col commissario prefettizio e poi, die-tro invito dello stesso, si presentarono al balcone, lentamente, per dare tutto il tempo ad un usciere di stendere per loro un ricco drappo sulla ringhiera. Ma videro abbasso la piazza vuota e deserti i balconi dirimpetto. Sicché la guardia del corpo corse in via Maestra a spedire in piazza quanti incontrava. A spintoni ne arrivò un centinaio, e stettero con gli occhi in alto ma con le braccia ciondoloni. Allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel grup-po chiedendo tra i denti: – Ohei, perché non battete le mani? – Le batterono tutti e interminabilmente nonché di cuore. Era stato un attimo di sbalordimento: su quel balcone c’erano tanti capi che in proporzione la truppa dove-va essere di ventimila e non di duemila uomini, e poi in prima fila si vedeva un capo che su dei calzoncini corti come quelli d’una ballerina portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera, con delle cerniere lampeggianti.
Intanto in via Maestra non c’era più niente da vedere: giunti in cima, i partigiani scantonarono. Una torma, che ad ogni incrocio s’ingrossava, corse ai due postriboli della città, con dietro un codazzo di ragazzini che per fortuna si fermarono sulla porta ad attendere pazientemente che ne uscisse quel partigiano la cui divisa o la cui arma li aveva maggiormente impressionati. In quelle due case c’erano otto professioniste che quel giorno e nei giorni successivi fecero cose da medaglie al valore.
A proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare col commissario prefettizio e poi, die-tro invito dello stesso, si presentarono al balcone, lentamente, per dare tutto il tempo ad un usciere di stendere per loro un ricco drappo sulla ringhiera. Ma videro abbasso la piazza vuota e deserti i balconi dirimpetto. Sicché la guardia del corpo corse in via Maestra a spedire in piazza quanti incontrava. A spintoni ne arrivò un centinaio, e stettero con gli occhi in alto ma con le braccia ciondoloni. Allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel grup-po chiedendo tra i denti: – Ohei, perché non battete le mani? – Le batterono tutti e interminabilmente nonché di cuore. Era stato un attimo di sbalordimento: su quel balcone c’erano tanti capi che in proporzione la truppa dove-va essere di ventimila e non di duemila uomini, e poi in prima fila si vedeva un capo che su dei calzoncini corti come quelli d’una ballerina portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera, con delle cerniere lampeggianti.
Intanto in via Maestra non c’era più niente da vedere: giunti in cima, i partigiani scantonarono. Una torma, che ad ogni incrocio s’ingrossava, corse ai due postriboli della città, con dietro un codazzo di ragazzini che per fortuna si fermarono sulla porta ad attendere pazientemente che ne uscisse quel partigiano la cui divisa o la cui arma li aveva maggiormente impressionati. In quelle due case c’erano otto professioniste che quel giorno e nei giorni successivi fecero cose da medaglie al valore.
Beppe Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba Ed. Einaudi
Altre opere dello stesso autore:
