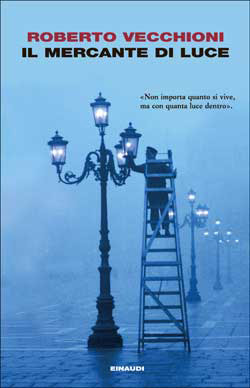
Un romanzo impetuoso, poetico e incentrato sull’amore per i libri e per la vita, questo libro ruota intorno a un grande ossimoro: un padre, un uomo disilluso che odia la vita, deve insegnare la bellezza della vita al figlio morente.
Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di progeria, una malattia che accelera vertiginosamente lo scorrere del tempo e condanna a una vecchiaia precoce. Suo padre, Stefano Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre trovato, anche se in maniera diversa. È un professore di letteratura greca, grandissimo e misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l’omologazione. Certo, è al tempo stesso un uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di più suo. E vuole credere con tutto se stesso che la bellezza che gli tempesta la memoria sia una luce cosí potente da svergognare il buio.
Questa è la cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa della vita e a un padre che gliene spiega il senso, l’unico che conosce. Il filo che li unisce, che trasforma il pensiero in un racconto che non potrà essere dimenticato, è la poesia greca: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell’unico tempo possibile, quello tra il mito e l’invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, Anacreonte, Sofocle, Euripide, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che troveranno il varco per salvarsi entrambi, perché non è possibile che «gli uccelli cantino quando passa la tempesta, e gli uomini non sappiano nemmeno esser felici del sole che gli resta». E potranno dire – forse – di non avere più paura, di morire e di vivere.
Vecchioni ha il grande dono di far amare la cultura. Un libro splendido, da leggere tutto d’un fiato.
Doveva lasciargli un dono, il più grande possibile…
E il dono è l’orgoglio di essere uomini e di vivere in questa rivelazione; perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro, senza rimpiangere e senza piangere.Ogni armonia è una conquista.
Estratto:
Passeggiava per il prato, Marco a fianco. Intorno la bruma padana, acquerugiola e disincanto, premessa o saluto a seconda dell’ora, in quel tempo e in quel mondo che non conosce luce fissa o giorno fatto da ottobre a marzo.
Epperò, in quella parvenza di mezza veglia e mezzo sonno, aveva già scoperto, fin da bambino, la stanza ideale perché i pensieri non scappassero dappertutto ma restassero ben dentro, si agitassero nella testa fino a prendere la forma di quel che chiamava “parolamento” e non sapeva che fosse già poesia. Le boschine del Po erano per lui un quadro di perenne sfondo, quasi l’assicurazione che dietro, da qualche parte, il mondo si poteva immaginare a piacimento, un po’ come dietro la “siepe”, o il “velo di Maya”: non aveva mai amato le trasparenze, i palazzi di cristallo, i ponti acrobatici che da un punto conducevano immancabilmente solo ad un altro punto; non si riconosceva nel finito e nel concluso. La nebbia suggeriva l’imperfetto, l’immaginabile, la bellezza, quella vera che è oltre, non di dietro, non di fianco, e si plasma e riplasma…
Insegnare greco significa specchiarsi nell’universo: astrarre, uscire, rientrare nei giorni, sapendoli finalmente per quel che sono: un insieme di parole, sparpagliate luci accese a comando per riconoscere le cose una alla volta dal fango al divino, una lunga fila di premesse del destino, se pure qualcuno si chiede del domani; uno sfidato equivoco, un incessante cercare di capirsi tra la mente e le cose.
Insegnare greco significa ricollocare al loro posto tempo e spazio, ferirli di spada nel loro interferire continuo coi sentimenti umani, ammaestrarli, esorcizzarli, tagliandoli la provocatoria offesa di esistere.
Questo sapeva, questo aveva sempre saputo, e anche che per lui non si era solo trattato di un mondo, l’unico possibile che veniva ad invaderlo. Non era solo quell’eternità del cuore e della ragione a prenderlo fino alla commozione; c’era al pari la bellezza inappuntabile della forma, quasi che le parole, il loro suono, il loro accoppiarsi e stringersi in frasi, versi e racconto fossero la spia diligente di una segreta ma sconfessabile armonia che regoli il mondo: la bellezza come consolazione al caos e alla sciagura: la bellezza quando l’occhio insegue a spiegarsi come e perché. Che meraviglioso verbo era αρμόζω, harmòzo, unire, collegare, dove ogni cosa è al suo posto, fugge dal ridondante, dallo sconnesso, dallo stridente particolare improprio, non consono, intruso. Nel disordinato ordine in cui si presentano i colori, o c’è una trama che l’anima sa leggere o c’è il nulla.[…]
C’era poco tempo. Tutti e due lo sapevano.
Doveva lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità e l’infelicità, l’amore e il disamore, il destino o Dio, la casualità inspiegabile di nascere e morire, oltre, oltre tutto questo che è un frullar d’ali in una melodia alta, più altà, immensa, che ci portiamo dentro al dilà dei margini del tempo dato.
E il dono è l’orgoglio di essere uomini e di vivere in questa rivelazione; perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro, senza rimpiangere e senza piangere.
Ma come, dove trovare una luce così potente da svergognare il buio?
E improvvisamente capì che ce l’aveva dentro quella bellezza, e lui, Quondam, altra bellezza non poteva dargli se non la sua, quella per cui aveva vissuto, l’unica che gli tempestasse la memoria, l’estate e l’inverno che le creature lasciano alla loro poesia.[…]
Doveva dirgli quello che passa e quello che resta di un uomo. E che non è importante di quello che si vive o di che si muore, ma il tuo dito a segnare una stella, anche se nessuno, quasi, riesce a leggerlo. Doveva lasciargli il “suo”, senza paura di farlo tremare, perché Marco era pronto.
– Ti racconterò una storia, anzi la storia delle storie, – disse.
– La storia delle storie?
– Sì, tu sai cosa significano àndres e andréia in greco…
– Certo: “uomini” e “valore”, sono quasi la stessa parola: non sei una cosa se non hai l’altra…
– Quasi. In realtà “valore” come interpretazione è fumosa, un bel po’ ballerina. L’andréia è un insieme di tanti significati che neppure immagini: è coraggio, forza, è l’animo, l’abito che porti, la fedeltà a un’idea, a te stesso, la nobiltà di un pensiero, l’orgoglio delle tue azioni, è in definitiva la “coerenza”, la storia di Aiace Telamonio dice tutto.
– Quello dell’Iliade?
– Anche, ma soprattutto quello di Pindaro, quello di Sofocle.[…]
– … il tormento di Aiace è quello della non appartenenza, di essere l’ultimo “buscadero” di un mondo che baratta il coraggio con la furbizia, con l’interesse, col dominio della razionalità. Aiace è l’uomo dell’istinto, del cuore che risponde per primo, e rappresenta un mondo che se ne va. È Ulisse il nuovo mondo, quello del calcolo, della nuova civiltà, lui domina il mare, non nuota nella sabbia. Ad Aiace non importa da quale sponda dell’esistenza guardare, se da quella della vita o della morte: l’esistenza di per sé è solo uno schiudersi o serrarsi chimico. Conta solo chi si è, di qua o di là del fiume:
Una nebbia improvvisa, una notte impenetrabile
Sospendono la battaglia dei greci; allora
Aiace, smarrito: «Zeus padre, – dice, – libera
da questa nebbia i figli degli Achei, porta il sereno:
poi sterminaci pure, ma nella luce»1.
È la luce che gli preme. E questo messaggio, Marco, è eterno, è di tutti gli uomini, in tutti i secoli. Noi non chiediamo per forza la vita, ma il coraggio di percorrerla.
– Noi?
– Sì, noi. E per chi hanno scritto a fare centinaia di uomini in migliaia di anni? Per le beghe, le faide, i tradimenti, le scaramucce, i duelli di un’ora, di un giorno? L’hanno fatto per noi, per noi. Aiace Talamonio chiuderà pure un’epoca, ne verrà un’altra, ma lui c’è sempre, a volte dolente, irriso, confuso fra i tanti Ulisse…
– Ma quel suicidio non è in fondo… non è una resa?
– Non cascarci, Marco. Come la guerra, i nemici uccisi, anche quel suicidio è una metafora, e potente. È, come ha scritto qualcuno, “l’estrema ratio di chi non ci sta a sottostare alle leggi del reale”, una festa di libertà… Insomma, è come se Aiace avesse detto: “Sapete che c’è di nuovo? Mi disgustate, io vi saluto”. Ricordati le sponde. Ricorda che è indifferente di qua o di là. Conta il tuo fiume, il tuo tratto di fiume:
O Morte, mia Morte, fissa me, adesso, fatti vicina;
non importa se ti starò accanto in eterno di là, e potrò
sempre parlarti2.
Sono le sue ultime parole quelle in cui si specchia: l’eroe è solo. Nessuno può chiedere all’ideale eroico di cozzare contro la meschinità della vita. Persino Ulisse ha la pietà di dire:
[…] lo vedo, noi esseri umani che siamo? Spettri,
impalpabile ombra3.
– Ha ragione Ulisse? Siamo così?
– No, ed è qui la differenza. Ulisse parla di ombre, Aiace di luce.[…]
– Tí touth’ ò dè légousin anthrópous erân?4 – fece Quondam a bruciapelo…
– Cioè? trasalì Marco.
– Scusa, ero sovrappensiero. «Ma cos’è quello che gli uomini chiamano amore ?» E’ la domanda da un milione di dollari che Fedra, disperata, persa nella passione per il figliastro Ippolito fa alla nutrice.
– E la nutrice?
«La cosa più dolce e insieme più dolorosa», le risponde…
– Ma non esiste amore, amore squassante, amore che ti tenga sveglio le notti, che Fedra, l’amore, l’eros, è ossessione, insopportabile astinenza fisica; non stringere a sè l’amante, non accoppiarsi con lui è morire ripetute morti. Fedra non designa un termine, non disegna un futuro: non c’è un orologio, un calendario, non esiste un progetto, un «faremo», «saremo» e non esistono perché questa passione brilla di una luce così intensa, così insopportabile alla vista che non può durare più di un attimo, un batter d’ali, poi è solo il buio dell’attesa nella speranza di un altro attimo simile.
– Ma… ma l’amore non è solo questo…
– No, no, abbiamo imparato a riempire il buioncon altre immagini. Abbiamo frenato i sensi, li abbiamo addomesticati con la tenerezza, con l’intelligenza. Ma questo altro tipo d’amore si è appropriato di un nome che non è suo, perché il delirio divino di cogliersi e fondersi è uno solo. Le cose più belle non durano, Marco, le cose più grandi sfolgorano, non spandono luce tenue per anni.
Tale follia d’amore mi si avvinghiò al cuore
e coprì di nebbia la luce degli occhi
mi strappò dal petto l’indifesa ragione5.
– E tu l’hai provato un amore così?
– Sì, ma sono caduto nell’altro troppo presto. E poi non c’è stato più nemmeno l’altro.
– E come comincia un amore?
– Il respiro, non respiri più, in senso letterale.
– E quando finisce?
– Magari, e questo è il peggio, finisce per uno ma non per l’altro. E allora ti ammali, ti annebbi, ti perdi, ti lasci, ti dimentichi di te, cambi pelle, aspetto, memoria, sogni. Sei un altro. Fai cose inspiegabili che non hanno senso e non c’è nemico per battersi o arrendersi, perché la tyche ti ha preso e piazzato in un’altra scena, in un altro teatro, in un’altra commedia del tutto insensata dove vivi per ipotesi, e continui a morire senza scampo. E il tuo corpo te lo ricorda, te lo ricorda eccome:
[…] nel petto il cuore ha un sussulto,
ti lancio un’occhiata
brevissima, e non so più
modulare parole,
mi s’imbroglia la lingua
e tace, sottile un fuoco
corre sotto la pelle, gli occhi
non vedono, rimbombano
le orecchie, sudo freddo, un tremito
totale mi prende,
pallida, verde più dell’erba.
A tu per tu con qualcosa
che è simile a morire 6.
E’ di Saffo, lo sai, ed è la più grande lirica, di addio di tutti i tempi, il film muto, lo stordimento fisico più fedele alla propria inadeguatezza davanti alla fine.
Tutt’e due, Fedra e Saffo, non possono nulla. Ma per Fedra è ancora più straziante, perché lei quell’amore non ha potuto e non doveva viverlo: se l’è cominciato, immaginato e finito da sé, da sola. Non può impazzire in quella passione proibita e non può cancellarla e rinsavire. Fedra non ha scampo.
Disgraziata che sono!
Cosa ho mai fatto?
Dove sono impazzita, dove
caduta, stordita da un demone?
Ahimè nutrice, coprimi il volto ancora,
quanta vergogna nelle mie parole!Scorrono dai miei occhi le lacrime,
lo sguardo è un grumo di vergogna:
tornare in me? Un tormento;
ma peggio restare nella follia.
Meglio morire e non saperne più7.
Saffo invece fa suo il dolore per curarsi l’anima ed è questa l’enorme differenza… Il tragico, il lirico, capisci? Sono due mondi.
Tirò fuori dalla borsa un piccolo volume.
– Ma esiste anche la felicità nell’amore, Marco, e un poeta, un grande poeta sa farne un fermo immagine che la eterni, che il tempo non scolori. Un grande poeta vola molto più in alto delle gelosie, delle paure, degli addii. In lei, in Saffo, è come se fosse «ora e qui» quello che magari non c’è neanche più.
Un grande poeta traduce la tyche in speranza, in illusione: rimbalza quello che per natura è l’amore, e cioè sofferenza, spasimo, delirio, in potenza del ricordo, dove tutto resta intatto, resta com’era, parole, gesti, carezze, baci, piacere perfetto.
Così, alla fine, ormai vecchia, poggiata la lira in un angolo, o relegata a qualcun’altra, eccola farsi il riassunto immaginario delle pene, delle sofferenze inevitabili, naturali in una vita di amori perduti, ed eccola confessare commossa di essere stata più forte del dolore:
… oh cara lira soave
… la vecchiaia ormai tutta la pelle
… e bianchi da neri i miei capelli
… e le ginocchia che non reggono
… ma io lo amo
questo divino vivere…
che mi donò
luminosa passione di sole
e la bellezza8.
Tienili, sono tutti i suoi frammenti: leggili quando vuoi e raccontameli.
Lo baciò sulla fronte.
(1) Iliade, XVII, vv. 643- 47
(2) Sofocle, Aiace, vv. 854 sgg.
(3) Sofocle, Aiace, vv. 125-26
(4) Euripide, Ippolito, v.347, trad. dell’autore
(5) Archiloco, fr.191 West, trad. dell’autore
(6) Saffo fr. 31 Lobel-Page
(7) Euripide, Ippolito, vv.239-48, trad. dell’autore.
(8) Papiro O, 1787, frr 1 – 2, trad. dell’autore.
Roberto Vecchioni, Il mercante di luce – Edizione Einaudi
In copertina: Berengo Gardin, Contrasto.
