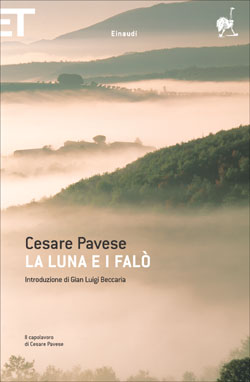
L’estate del 1949, Cesare Pavese vive una contentezza insolita, che assomiglia molto alla felicità di chi sta per generare qualcosa e, allo stesso tempo, il timore che un bene prezioso possa perdersi. Due mesi dopo, dal 18 settembre al 9 novembre, il romanzo è iniziato e finito. La modesta «Divina Commedia» ha preso forma ed è il romanzo più riuscito dello scrittore, uno dei punti fermi della narrativa italiana del Novecento. Esso rientra sia nel genere realistico – simbolico che in quello di ambiente naturalistico in quanto descrive ampiamente le langhe piemontesi. Il protagonista, Anguilla, all’indomani della Liberazione torna al suo paese delle Langhe dopo molti anni trascorsi in America e, in compagnia dell’amico Nuto, ripercorre i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza in un viaggio nel tempo alla ricerca di antiche e sofferte radici.
Gli elementi che contraddistinguono l’opera sono temi molto cari allo scrittore: il viaggio di ritorno, inteso come riconoscimento delle proprie origini e dei luoghi d’infanzia; la campagna, intesa come sedimento del passato che non subisce alcuna mutazione e luogo estraneo alle vicende terribili del Mondo; i falò, intesi come riti sacrificali di antiche credenze, riti propiziatori di vita e fertilità, ma anche simbolo di morte e di violenza.
La Luna e i falò è il romanzo più conosciuto, letto e tradotto di Cesare Pavese, l’opera che ha segnato la sua raggiunta maturità stilistica.
Un libro da leggere e ri-leggere perché si apprezza solo con il passare del tempo.
L’epigrafe del romanzo è “for C. Ripeness is all” (per Costance. La maturità è tutto).
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Estratto:
L’altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendìo così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima – e in cima, chi sa dove, ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri – era come scorticata dall’inverno, mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce asciutta, digradare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta una stoppa di meliga. Dalla stalla muggì un bue, e nel freddo della sera sentii l’odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque più così pezzente come noi.M’ero sempre aspettato qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato; tante volte m’ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com’era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire ch’era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull’aia. Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di colture non importi. Certamente, di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici; io stesso, se di quella riva fossi stato padrone, l’avrei magari roncata e messa a grano, ma intanto adesso mi faceva l’effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno, e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l’uva e la si vende a Canelli; si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C’è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d’occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l’esperienza. Possibile che a quarant’anni,e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese?
Cesare Pavese, (da) “La Luna e i Falò”, 1950.
Altre opere dello stesso autore:
- Dialoghi con Leucò – Cesare Pavese
- Feria d’agosto – Cesare Pavese
- Fuoco grande – Cesare Pavese Bianca Garufi
- Il compagno – Cesare Pavese
- Il mestiere di vivere – Cesare Pavese
- La bella estate – Cesare Pavese
- La casa in collina – Cesare Pavese
- La spiaggia – Cesare Pavese
- Lavorare stanca – Cesare Pavese
- Le poesie – Cesare Pavese
- Lettere 1926-1950 – Cesare Pavese
- Paesi tuoi – Cesare Pavese
