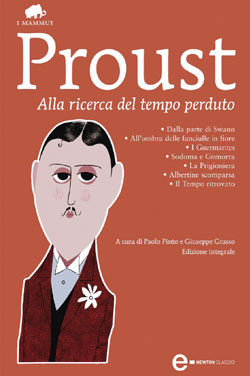 Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) è l’opera più importante di Marcel Proust, scritta tra il 1909 e il 1922, pubblicata in sette volumi tra il 1913 e il 1927. Si colloca tra i massimi capolavori della letteratura universale per vari motivi, ma soprattutto per l’ambizione letteraria e filosofica che l’autore ha riposto in quest’opera (intuire di cosa il tempo è composto per cercare di fuggire il suo corso).
Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) è l’opera più importante di Marcel Proust, scritta tra il 1909 e il 1922, pubblicata in sette volumi tra il 1913 e il 1927. Si colloca tra i massimi capolavori della letteratura universale per vari motivi, ma soprattutto per l’ambizione letteraria e filosofica che l’autore ha riposto in quest’opera (intuire di cosa il tempo è composto per cercare di fuggire il suo corso).
Il primo volume apparve il 14 novembre 1913, Marcel Proust lo pubblica a sue spese col titolo Du côté de chez Swann ( Dalla parte di Swann o La strada di Swann): vi appaiono i temi della dolorosa nostalgia per l’infanzia, dell’amore e della gelosia (attraverso il personaggio di Swann), del carattere allusivo di certi «momenti», che sembrano aprire una prospettiva misteriosa e sfuggente verso una realtà assoluta, oltre al fluire irreversibile del tempo. Altri temi importanti – le «intermittenze del cuore», la trasformazione delle persone attraverso il trascorrere delle generazioni e i sommovimenti dell’assetto sociale – non vi sono ancora svolti esplicitamente, così come non risulta ancora chiarito l’assunto profondo dell’opera (il cui piano è stato tracciato fin dal 1912-’13), che doveva rivelarsi progressivamente nelle parti successive del romanzo. L’incomprensione non durò a lungo: nel 1918 esce la seconda parte della Recherche: À l’ombre des jeunes filles en fleur (All’ombra delle fanciulle in fiore), premio Goncourt 1919. Nel 1920 e il 1922 usce Le côté de Guermantes (I Guermantes) e Sodome et Gomorrhe (Sodoma e Gomorra). Nel 1923 esce La prisonnière (La prigioniera); 1927 esce La fugitive ossia Albertine disparue (La fuggitiva o anche Albertine scomparsa) e Le temps retrouvé (Il tempo ritrovato).
Ma, anche considerando le cose più insignificanti della vita, noi non siamo un insieme materialmente costituito, identico per tutti, e di cui ciascuno non ha che da prendere visione come di un capitolato d’appalto o di un testamento; la nostra personalità sociale è una creazione del pensiero altrui. Anche l’atto così elementare che chiamiamo «vedere una persona che conosciamo» è, in parte, un atto intellettuale. Riempiamo l’apparenza fisica dell’essere che vediamo con tutte le nozioni che possediamo sul suo conto, e nell’immagine totale che ci rappresentiamo, queste nozioni hanno certamente la parte più considerevole.
Estratto:
[…]
Con gli occhi non lasciavo mia madre, sapevo che, una volta a tavola,non mi avrebbero consentito di restare per tutta la durata della cena e che, per non contrariare mio padre, la mamma non avrebbe permesso che la baciassi più volte davanti agli altri, come se fossimo stati in camera mia. Così mi ripromettevo, in sala da pranzo, quando si fosse cominciato a mangiare e io avessi sentito approssimarsi l’ora, di fare, prima di quel bacio, che sarebbe stato breve e furtivo, tutto ciò che potevo fare da solo, scegliere con lo sguardo il punto della gota che avrei baciato, preparare il pensiero per avere la possibilità, grazie a quel mentale inizio di bacio, di consacrare per intero il minuto che la mamma mi avrebbe accordato, a sentire la sua gota contro le mie labbra, come un pittore che, potendo contare solo su brevi sedute di posa, prepara la tavolozza, e ha fatto già prima a memoria, sulla base dei suoi appunti, tutto ciò per cui può a stretto rigore fare a meno della presenza del modello. Ma ecco che, prima che suonassero per la cena, il nonno ebbe l’inconscia ferocia di dire: «Il bambino ha l’aria stanca, dovrebbe salire di sopra e mettersi a letto. Del resto, stasera si cena tardi». E mio padre, che non teneva così scrupolosamente fede ai patti come la nonna e la mamma, disse: «Sì, andiamo, vai a letto». Feci per baciare la mamma; in quell’istante risuonò la campanella della cena. «Ma no, via, lascia stare tua madre, vi siete già dati abbastanza la buonanotte, queste manifestazioni sono ridicole. Suvvia, sali!» E mi toccò andarmene senza viatico; mi toccò salire la scala, gradino dopo gradino, come dice l’espressione popolare, a «malincuore», salendo contro il mio cuore che voleva tornare accanto a mia madre, poiché lei non gli aveva dato, baciandomi, licenza di seguirmi. Quella scala detestata, su per la quale m’inoltravo sempre così tristemente, emanava un odore di vernice che aveva in qualche modo assorbito, fissato, quella specie particolare di sofferenza che provavo ogni sera, e la rendeva forse ancor più crudele per la mia sensibilità poiché, sotto quella forma olfattiva, la mia intelligenza non poteva più prendervi parte. Quando dormiamo, e percepiamo un mal di denti ancora solo come una ragazza che ci sforziamo duecento volte di seguito di tirar fuori dall’acqua o come un verso di Molière che ci ripetiamo senza posa, è un gran sollievo risvegliarci e avvertire che la nostra intelligenza può liberarci dall’idea del mal di denti, da ogni travestimento eroico o cadenzato. Era l’inverso di quel sollievo ciò che provavo quando la sofferenza di salire in camera entrava dentro di me in modo infinitamente più rapido, quasi istantaneo, insidioso e brusco al tempo stesso, con l’inalazione
molto più tossica di un’insinuazione morale dell’odore di vernice tipico di quella scala. Una volta in camera, fu necessario chiudere tutte le uscite, serrare le imposte; scavare la mia propria tomba, disfacendo le coperte, indossare il sudario della camicia da notte. Ma prima di seppellirmi nel letto di ferro che era stato portato nella camera, perché d’estate avevo troppo caldo sotto le cortine di
reps del letto grande, ebbi un moto di ribellione, volli tentare un’astuzia da condannato. Scrissi a mia madre, supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dire per lettera.
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann – A cura di Paolo Pinto e Giuseppe Grasso
